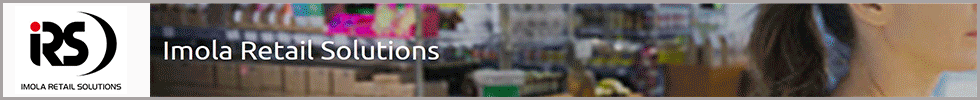News:
Conad - Grande Viaggio Insieme. 2019 Castello Aragonese 4 ottobre ore 16,00 “La comunità operosa a confronto nella filiera dell’uva da tavola”.
- Dettagli
- Creato: Lunedì, 07 Ottobre 2019 10:51
 L’Italia è il secondo produttore al mondo di uva da tavola dietro al Cile e davanti a Stati Uniti e Sudafrica. Con una media produttiva 2009-2018 di oltre 1,1 milioni di tonnellate, pari ad un valore della produzione oscillante tra 1,2 e 1,5 Mld di €, il nostro Paese è il principale riferimento europeo in questo settore dove le esportazioni rappresentano una quota di mercato crescente (31% nel 2004, 45% nel 2018) a fronte di un mercato interno sostanzialmente stabile. L’uva da tavola è il secondo prodotto frutticolo per valore delle esportazioni dopo le mele.
L’Italia è il secondo produttore al mondo di uva da tavola dietro al Cile e davanti a Stati Uniti e Sudafrica. Con una media produttiva 2009-2018 di oltre 1,1 milioni di tonnellate, pari ad un valore della produzione oscillante tra 1,2 e 1,5 Mld di €, il nostro Paese è il principale riferimento europeo in questo settore dove le esportazioni rappresentano una quota di mercato crescente (31% nel 2004, 45% nel 2018) a fronte di un mercato interno sostanzialmente stabile. L’uva da tavola è il secondo prodotto frutticolo per valore delle esportazioni dopo le mele.
L’uva da tavola rientra nel novero dei prodotti stagionali, ambito nel quale la programmazione delle colture riveste un ruolo particolarmente rilevante. Gli andamenti stagionali hanno un impatto rilevante sul prezzo e quindi sui consumi.
Dal punto di vista fondiario siamo di fronte al consueto paesaggio parcellizzato all’interno del quale si individuano alcuni grandi produttori privati che dispongono di fondi propri ai quali tendono ad aggregare più o meno vaste costellazioni di piccoli produttori che condividono protocolli fitosanitari e programmi comuni di filiera. Molto rilevante, in questo settore, è anche il ruolo dei commercianti all’ingrosso che svolgono un ruolo diretto o indiretto di organizzatori della produzione.
Nel corso degli ultimi anni nel campo dell’uva da tavola, all’interno di un processo che interessa tutto il comparto ortofrutticolo legato alla stagionalità, ha assunto centralità il tema della diversificazione delle varietà con l’intento di ampliare l’offerta e allungare la stagionalità di un prodotto caratterizzato da un ciclo di raccolta-distribuzione e consumo tradizionalmente molto breve. La ricerca varietale è appannaggio di grandi realtà multinazionali che in questi anni hanno messo a punto numerosi brevetti a partire dal grande spartiacque rappresentato dall’introduzione dell’uva senza semi (apirene), che ha conosciuto una vasta diffusione nei mercati internazionali, di fatto soppiantando le varietà tradizionali.
In un quadro in cui l’Italia ha mantenuto a lungo una leadership produttiva incontrastata basata sulle varietà tradizionali (Regina, Vittoria, Italia) l’avvento delle nuove varietà ha indubbiamente spiazzato gli operatori nazionali che hanno faticato, e faticano ancora oggi, ad adottare le necessarie iniziative di adattamento delle colture. L’esordio sul mercato dei club varietali anche per l’uva da tavola ha introdotto una importante novità nel campo della programmazione della produzione.
L’uva è un prodotto con grandi caratteristiche di delicatezza che deve essere difesa da attacchi parassitari e dagli agenti atmosferici lungo tutto il ciclo produttivo, richiedendo particolare perizia e cura da parte degli operatori al campo cui spetta il compito di portare a maturazione i prodotti attraverso un costante monitoraggio delle colture.
Nell’ambito della filiera dell’uva da tavola il rilievo posto dagli interlocutori sul valore delle professionalità al lavoro al campo e sull’impatto occupazionale del settore è giustificato dal semplice dato di partenza per cui in ambito ortofrutticolo la coltivazione dell’uva da tavola è tra quelle che richiede il maggior numero di ore/ettaro di manodopera, esprimendo un fabbisogno medio di 750 ore/ha rispetto alle 500 del kiwi, alle 400 di mele e pere. Il mercato del lavoro della coltivazione dell’uva da tavola, come per altro quello di altri comparti ortofrutticoli a base stagionale, si caratterizza per una segmentazione interna nella quale si riconosce un nucleo ristretto specializzato e impegnato nelle attività al campo per tutto l’anno ed un più vasto bacino di manodopera relativamente poco qualificata che viene attivato nella stagione della raccolta.
Se il panorama relativo all’effettività della contrattazione sembra restituire un processo di lento miglioramento del contesto con una dichiarata volontà delle parti sindacali nel trovare punti di incontro e traiettorie di lavoro convergenti, diversa è invece la situazione che attiene al vasto bacino di manodopera, a prevalenza femminile, ingaggiato nella stagione della raccolta, dove invece le condizioni di lavoro al campo presentano ampi margini di miglioramento.
Se in materia di sostenibilità sociale esistono ampi margini di miglioramento, per quanto invece attiene al tema della sostenibilità ambientale il tema appare meno connotato da urgenza, anche in virtù di una tradizione agricola che, con riferimento all’uva da tavola, si è sempre dimostrata piuttosto attenta a non eccedere nella ricerca delle rese, avendo in questo caso sì ben presente la necessità di preservare lo stato di salute della terra nel lungo periodo. Su questo elemento di sostenibilità ambientale ereditato dalla tradizione sono stati successivamente innestate le opportunità pratiche di lotta integrata con ridotto ricorso alla chimica industriale di sintesi in qualche caso sostituita dall’utilizzo di prodotti naturali in una logica di economia circolare e la razionalizzazione dell’acqua per l’irrigazione.
Due sono le grandi aree geografiche di produzione di uva da tavola in Italia: Puglia e Sicilia. In queste due regioni si coltiva il 95% della produzione annua, ripartita tra un 60% in Puglia ed un 35% in Sicilia. Tre sono le province nelle quali, all’interno delle due regioni, si concentrano la produzione e le superfici agricole dedicate: Taranto, Bari e Barletta-Andria-Trani in Puglia; Catania, Agrigento e Ragusa in Sicilia. In queste sei province si concentra l’80% della produzione di uva da tavola.
Prendendo in esame l’ultimo decennio (periodo 2009-2018) appare evidente come la produzione e le superfici coltivate ad uva da tavola siano nettamente diminuite, con un calo complessivo del 20% nel periodo 2009-2012 ed una successiva tenuta dei livelli produttivi nel periodo 2013-2018. In particolare il calo ha interessato soprattutto la Puglia (-30%), laddove in Sicilia le produzioni sono cresciute del 10-12%. Questa dinamica ha modificato sensibilmente le quote di produzione delle due regioni. Se infatti nel 2009 la ripartizione tra Puglia e Sicilia a livello nazionale era di 69,3% rispetto al 24,7%, nel 2018 la quota pugliese è scesa al 59,5% mentre quella siciliana è salita al 34,9%.
A fronte di questa complessiva riduzione delle produzione sono aumentate le rese per ettaro, tradizionalmente più alte in Puglia di circa il 15% rispetto alla Sicilia, con una crescita media del 14% sia nelle aree pugliesi che in quelle siciliane. Attualmente le due province con le rese maggiori sono Taranto (300 q/ha) e Catania (290 q/ha), seguite da Ragusa e dalla provincia di BAT.
Due sono le aree produttive localizzate in Puglia vocate all’uva da tavola. La prima è localizzata nella provincia di Taranto, in particolare nell’entroterra dell’arco ionico compreso tra Grottaglie, Massafra e Castellaneta. La seconda è prosperata intorno a Bari, sia nella parte meridionale della provincia (Rutigliano), sia nella parte settentrionale verso Barletta, con una più spiccata propensione commerciale, laddove le produzioni ioniche rappresentano invece i vertici produttivi per qualità e rese, non solo a livello regionale, ma anche nazionale.
L’area apulo-ionica, dove l’agricoltura occupa nella sola provincia di Taranto circa 30 mila persone ed un numero altrettanto consistente di lavoratori stagionali, punta a strutturare in maniera sempre più efficiente le filiere agroalimentari puntando a sviluppare moderne forme di aggregazione tra i produttori (OP), aumentando la diffusione di saperi scientifici come base per innovare prodotti (ad esempio le varietà d’uva da tavola), processi di coltivazione (a minore impatto ambientale), ma soprattutto provando a mettere a valore il rapporto con le rilevanti potenzialità logistiche presenti a Taranto (il porto con la sua prossima Zona Economica Speciale) e Grottaglie (aeroporto) attraverso l’avvio di iniziative come Agromed sotto la regia della CCIAA di Taranto. La struttura pubblica di prossima realizzazione si affianca ad iniziative private che fanno capo ai grandi produttori/commercianti privati della filiera dell’uva, ma anche a quelle appena avviate da gruppi privati del settore distributivo come quella presente a San Giorgio Jonico.
L’intenzione dell’operatore portuale tarantino è perciò di avviare a breve l’attività di import-export di contenitori per poi puntare al transhipment e all’attivazione dell’hub intermodale su ferro e gomma, considerato il vantaggio localizzativo di un porto prossimo ma non incorporato alla città, con accesso immediato alle vie di comunicazione regionali, interregionali e nazionali. Le aspettative relative al rilancio e allo sviluppo del porto vanno ben oltre le prospettive legate all’uva da tavola o al pur rilevante comparto agroalimentare che comprende Puglia, Basilicata e parte della Calabria. Lo spazio di rappresentazione del porto si inscrive all’interno del bacino mediterraneo e delle rotte che si prolungano dal canale di Suez all’Europa e che attualmente hanno nel porto del Pireo il principale riferimento logistico di transhipment.
Le probabilità di affermazione di un più ampio destino per il porto di Taranto si gioca all’interno di equilibri e scelte che dipendono dalla sfera decisionale europea, in un momento nel quale l’Europa fatica ad elaborare una strategia continentale complessiva capace di interagire in maniera efficace con le strategie aggressive messe in campo dalla potenza cinese tese dal controllo delle grandi vie di comunicazione tra Asia ed Europa.